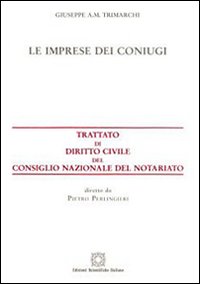Le imprese dei coniugi
- Editore
- Edizioni Scientifiche Italiane
- Autori
- Giuseppe Antonio Michele Trimarchi
- Categoria
- Diritto
- Pagine
- 344
- Pubblicato
- Ottobre 2009
- Codice ISBN
- 9788849518375
- Prezzo di listino
- €
48,00 - a Voi riservato
- € 45,60
Descrizione
L’attualità di una riflessione approfondita sui temi dell’impresa individuale e collettiva esercitate da soggetti coniugati in regime di comunione legale muove, almeno, da un duplice ordine di esigenze. La prima è di carattere generale, dal momento che il tema appare omologato nelle conclusioni, specie giurisprudenziali, tendenti all’esuberante sopravvalutazione dell’incidenza del regime legale sugli oggetti di che trattasi, quasi che essi avessero una sorta di naturale attitudine alla contitolarità, ontologicamente suppletiva, talora, al sistema del regime stesso, oltre che alla lacunosità del disposto positivo. La seconda, di carattere operativo, derivante dalla significativa circostanza per cui il tema dellazienda, e dell’impresa individuale e collettiva, necessita una ponderata valutazione di tutti gli interessi in gioco, che non si esauriscono nella giustapposizione di quelli dei coniugi, o nella rilevanza dell’affidamento dei terzi correlato alla «mera» vicenda circolatoria di beni, ma interferiscono, in modo significativo, con gli interessi di tutti quei terzi che, più in generale, hanno relazioni con l’impresa del o dei coniugi, e con l’organizzazione dell’impresa collettiva in cui siano a vario titolo coinvolti coniugi. Per questo, innanzitutto, s’è evidenziato il concetto di «azienda comune» come fattispecie eteroqualificata sul piano della contitolarità rispetto al meccanismo dell’acquisto e si è studiato il concetto di «gestione comune» quale fondamento di una contitolarità, la cui essenza, lungi dall’essere spiegata con la nozione tecnica di acquisto, si è dimostrato coincidere con il valore dell’iniziativa economica. Esso ha rilevanza costituzionale, ed è apparso, quindi, conformativo della fattispecie «azienda personale» in tutti i suoi aspetti. In secondo luogo, s’è rivolta attenzione al rapporto tra comunione legale e titolarità di partecipazioni sociali acquistate, manente matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi evidenziando, in particolare, le differenze sovente ricondotte alla dicotomia «partecipazioni in società di persone» e «partecipazioni in società di capitali», mostrando la lacunosità e la frammentarietà delle ricostruzioni, nonché la generale inadeguatezza dei criteri esegetici proposti. La revisione critica delle più frequenti conclusioni, ed in particolare dei criteri interpretativi comunemente utilizzati per includere, e (meno frequentemente) escludere, le partecipazioni sociali nel o dal regime di comunione legale dei beni, unitamente al respingimento dell’abuso di categorie spesso considerate addirittura pre_esistenti agli stessi interessi che esse si propongono di disciplinare, ha imposto una ricostruzione del concetto di comunione di partecipazione sociale, la quale non poteva che muovere dal dettato normativo, che ben conosce e disciplina la «comunione» di talune partecipazioni. Tale articolazione, peraltro, è sembrata in condizione di metabolizzare ed equilibrare tutti gli interessi realmente in gioco, e la sua evidente propensione a precludere la scissione tra titolarità e legittimazione è apparsa illuminante al fine della soluzione del problema. Da qui l’idea dell’incompatibilità assoluta della partecipazione sociale con il regime di comunione legale dei beni.